Fortunato Stefano D’Arrigo , nato ad Alì Terme nel 1919 , in provincia di Messina, morto a Roma nel 1992, questo il nome completo dell’autore di “Horcynus Orca”, appartiene di diritto a quella suprema genìa di autori al di fuori del tempo ordinario, che vanno considerati come fosse sempre una prima volta per scoprirne di continuo, avendo sensibilità e accortezza, le sfaccettature lirico linguistiche,epico nostalgiche che sopravanzano qualsivoglia ambiguità di critica interpretativa ufficiale e non.
Come é forse risaputo, sin dal 1975, anno della definitiva pubblicazione per i tipi Mondadori, preceduta da una stesura risalente al lontano 1960, già corretta in bozza e mai arrivata in libreria, l’attenzione intorno al romanzo del Nostro ha oscillato dai consensi più entusiastici a pregiudiziali perplessità qua e là affioranti da parte di meno attenti esegeti, fra l’altro, spesso colti in flagrante,vale a dire nell’atto di pontificare senza aver letto, né prima né dopo.
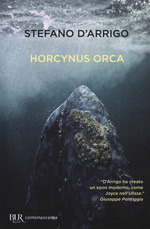 Più spesso di quanto si possa credere, dal momento che accostarsi al romanzo capolavoro del D’Arrigo esige, per così dire, un passionale addestramento nel percepire, di pagina in pagina, più di mille, ossessivi soliloqui diuturni e, peggio, notturni a causa di virgole e vocaboli da risparmiare o sopprimere, umanizzandone i significati fino allo spasimo della intuizione/inventio….
Più spesso di quanto si possa credere, dal momento che accostarsi al romanzo capolavoro del D’Arrigo esige, per così dire, un passionale addestramento nel percepire, di pagina in pagina, più di mille, ossessivi soliloqui diuturni e, peggio, notturni a causa di virgole e vocaboli da risparmiare o sopprimere, umanizzandone i significati fino allo spasimo della intuizione/inventio….
Come non rammentare il tanto e sofferto volgere che, da dietro le quinte della scrittura, prelude finalmente alla considerevole mole del magmatico racconto cui fa da sfondo, per chi lo ignorasse, quell’omerico Stretto ulissiano, pare pleonastico ma non è, che dopo millenni ancora cinge di respiro catartico la città di Messina,ove chi scrive è nata, a torto ritenuta turisticamente degna solo di un frettoloso passaggio in ombra, rispetto alle altre province consorelle dell’Isola!
Cosicché, sin dai primordi narrativi, l’autore per circa una ventina d’anni, si prepara strenuamente a dipanare il bozzolo entro cui sente fremere la sua “creatura” , a cominciare giusto dal titolo che, per parecchie lune e diversi annosi tentativi , non riuscirà a delinearsi nella morgana limpidezza in grado di subitamente impressionare il lettore, in ideale attesa, si fa per dire, di essere tramortito, ovviamente a livello letterario, con miriadi di immagini e un periodare vorticoso proprio come quei “garroffoli”, o mulinelli a pelo d’acqua, la cui pericolosità temono i naviganti calabro-siculi fin dall’antichità.
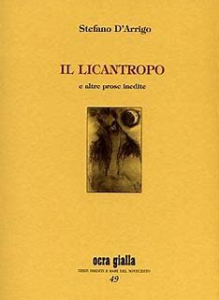 Si va quindi da “La testa del delfino” che poco s’addice alle specie marine maggiormente protagoniste della vita di queste acque a “I giorni della fera” che, nelle precipue intenzioni creative del Nostro, equivale all’esistere di un animale selvaggio dal triplice sembiante mostruoso, in un’accozzaglia di forme tra balena,pescecane e pescespada,quest’ultimo essendo lo stesso che di solito spadroneggia nelle più superbe ricette marinare alla messinese.
Si va quindi da “La testa del delfino” che poco s’addice alle specie marine maggiormente protagoniste della vita di queste acque a “I giorni della fera” che, nelle precipue intenzioni creative del Nostro, equivale all’esistere di un animale selvaggio dal triplice sembiante mostruoso, in un’accozzaglia di forme tra balena,pescecane e pescespada,quest’ultimo essendo lo stesso che di solito spadroneggia nelle più superbe ricette marinare alla messinese.
Al momento,la Fera, quasi un’invocazione a mostrare la sua vera natura nel corso dei capitoli, ammorba di umori pestilenziali, guatando dalle profondità di questo braccio di mare dove non staziona quasi più il falco pecchiaiolo ma in compenso ci si può imbattere nel mito della “Horcynus Orca” , crudelissima predatrice di umani indifesi e luoghi ineffabili, nell’atto di emergere dagli abissi in veste di orrido fascino che ha trovato il suo definitivo traguardo, ovvero titolo dell’ opera.
E la trama? E i protagonisti? Ci sono eccome: l’una va individuata con garbo, lasciandosi permeare da quella lingua arcaico /dialettale, agrodolce come in certi templi della rinomata cucina isolana, gli altri, cioè a dire il marinaio ‘Ndrja Cambrìa, “nocchiero semplice della fu regia marina” di ritorno /nostos dalla guerra, “maro figlio”,destinato a morte pressoché patriottica nelle fasi conclusive della storia, il quale,nella furia di riappropriarsi di carnali emozioni, si accompagna volentieri a femminelle e sirenusse, un momento prima di farsi maternamente irretire dall’altra densa figura ad altorilievo, Ciccina Circé, che già nel nome “ s’incantesimano”,parola di autore, maliose pupille e neri serpigni capelli “unti e lustri” all’olio d’oliva. Con pochi colpi vigorosi di penna i tratti di lei, “babbiona”,un po’ maga,un po’ commediante di fino , s’ergono al di sopra del racconto, divenendo infine il Romanzo maiuscolo di acque e fere e barche e ricerca di ami, si dice più di cinquanta , amorosamente raccolti alla stregua di esperto fiocinatore, da Stefano D’Arrigo, prima di iniziare la strabiliante avventura di ricondurre “ ad unum” tutti i poemi che hanno narrato in prosa e in versi le eroiche gesta di caccia grossa nel “suo”scill’e cariddi.
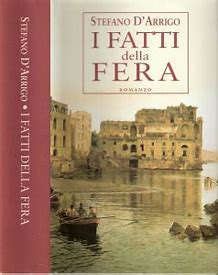 Un rovello che talvolta sa di impaludamento stigio, avvertito nelle migliaia di appunti e foto e riviste che intrattengono i cultori su rigogliose esistenze di mare, mentre ci si strugge di sensazioni su ciò che in ultimo vale davvero la pena di custodire dagli assalti dell’Orca, male del mondo, la quale,nel frattempo, non smette di emanare i suoi fetori , agitando lungamente le onde e gli animi.
Un rovello che talvolta sa di impaludamento stigio, avvertito nelle migliaia di appunti e foto e riviste che intrattengono i cultori su rigogliose esistenze di mare, mentre ci si strugge di sensazioni su ciò che in ultimo vale davvero la pena di custodire dagli assalti dell’Orca, male del mondo, la quale,nel frattempo, non smette di emanare i suoi fetori , agitando lungamente le onde e gli animi.
Nel corso degli innumerevoli e defatiganti vagabondaggi in cerca della frase perfetta, Stefano D’Arrigo ebbe sempre al suo fianco la moglie Jutta, costantemente armata di tenacia e abnegazione,di modo ché, lo scrittore sentì il bisogno di esprimerle eterna gratitudine dedicando a lei la sua monumentale fatica letteraria.
Nel riguardare le foto, non molte, che lo ritraggono, il D’Arrigo appare e dispare,schivo e ritroso,forse vagamente attonito nel presentire il ruolo demiurgico che il suo capolavoro,una volta giunto al compimento, avrebbe assunto nel corso della letteratura italiana novecentista,svelando in modo indefettibile a sé medesimo e ai lettori la certezza di poter vivere solo “dove il mare è mare”…dalla chiusa del romanzo! .
Mirella Violi





