Non era semplice a Bova approvvigionarsi d’acqua. Quella da bere veniva attinta, dopo estenuanti file, a Sifoni, in paese, oppure nei dintorni a Petrefìlipu, Clistì e Verceu. L’erudito bovese Don Domenico Alagna, in un suo scritto del 1775, facente parte di più vasta opera,[1] ci parla soltanto delle prime tre per cui pare ragionevole ipotizzare che la quarta sia sgorgata dopo tale data. Dopo aver magnificato l’aria pura di Bova, scrive l’Alagna a proposito dell’acqua: “Questa è in tre fontane attorno alla città ed è differente in ciascuna di esse. Nella prima, chiamata Petrofilippo, […] è tanto preziosa e pura che […] pesata con tutte le altre acque del regno di Napoli, coll’idrometro, portò il primato della leggierezza e squisitezza e nelle altre rare sue qualità. […] La seconda fontana, chiamata Syphone, è un poco più grossolana l’acqua […] (e qua con l’Alagna concorda il popolino che sentenzia: “L’acqua di Sifoni moddhija li plemoni”). La terza fontana, poi, detta Clistì, è rimarchevole più di tutte per la qualità e virtù dell’acqua, la più atta e confacente per ingrassarsi i cavalli ed altri giumenti […]”.
Questa acqua da bere, all’epoca in cui scrive l’Alagna e fino agli anni ’50 del secolo scorso, era portata in casa dalle donne con gli orci sulla testa o, a dorso d’asino, nei barili. Quest’ultimi venivano poi allogati nella bariddherìa, un cavalletto con bracci orizzontali su cui si poggiavano i barili che potevano facilmente venir fatti ruotare su sé stessi per farne uscire l’acqua agevolmente. Per l’acqua pe’ servimentu, invece, si provvedeva da pozzi e cisterne e riempiendo balconi e terrazze coi più svariati recipienti ad ogni scroscio di pioggia.

Il prezioso liquido perciò, a causa della difficoltà di approvvigionamento, veniva usato con parsimonia e, quando possibile, riciclato (ad es.: si lavavano i piatti con la cenere e non con la sapunina per poter poi innaffiare l’orticello o li gastri).
Monsignore, da questo punto di vista, era fortunato. Il pozzo che possedeva nell’orto, vicino al peripigghiu della Cattedrale, dava acqua che era buona da bere.
E per bere inizialmente la usarono alcuni muratori che, sorvegliati dal canonico Nicolosi, stavano eseguendo alcune riparazioni nella Cattedrale. Però, da qualche giorno, avevano preso l’abitudine d’attingere da quel pozzo anche l’acqua necessaria ai loro lavori.
Don Giovannino, il Monsignore, per un po’ lasciò fare poi si spazientì. Era un uomo pio, caritatevole, comprensivo, modesto e non indulgeva ad alcun vizio, era anche paziente ed usava un linguaggio misurato quale conveniva al suo stato. Un sant’uomo. Ma anche i santi qualche volta perdono la pazienza e si lasciano scappare qualche espressione forte, magari mascherata da spiritoso doppio senso o si lasciano andare a qualche gesto poco ortodosso.
Così, dunque, quando il Monsignore piombò in Cattedrale per fare le sue rimostranze per tutta quell’acqua potabile cassariata così, per meglio far intendere il llunchiamentu che ciò glicausava, prese ad agitare significativamente le mani, aperte a palmo in su, davanti al decimo bottone della tonaca dietro cui era nascosto il cavallo dei pantaloni che nascondeva i mutandoni di lana con tutto quello che dentro c’era da nascondere:
- Bisogna smetterla con tutto questo spreco di acqua da bere!
Mastro Pietro, il capomastro, si risentì e, offeso, voleva abbandonare il lavoro ma il canonico Nicolosi intervenne a far da paciere e, con tono di ironica riprovazione, ammonì:
- Calma, calma, Monsignore! Non dimenticate le opere di misericordia. Anche il dono di una goccia d’acqua ci acquista meriti agli occhi di Dio!
E Don Giovannino, agitando nuovamente le mani davanti a quel decimo bottone: ”…e cunsiderati a mia cu ddhu’ bariddhi…?!”
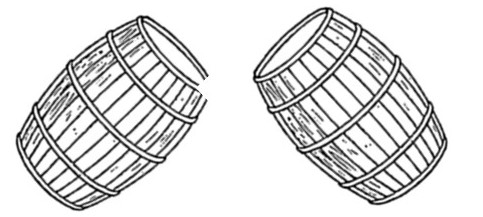
[1] “Delle città d’Italia e sue isole adiacenti”. Opera ideata e coordinata da Cesare Orlandi in cui Bova è presente con ben 52 pagine. Pregevole la ristampa a cura di Francesca e Pasquale Tuscano.





